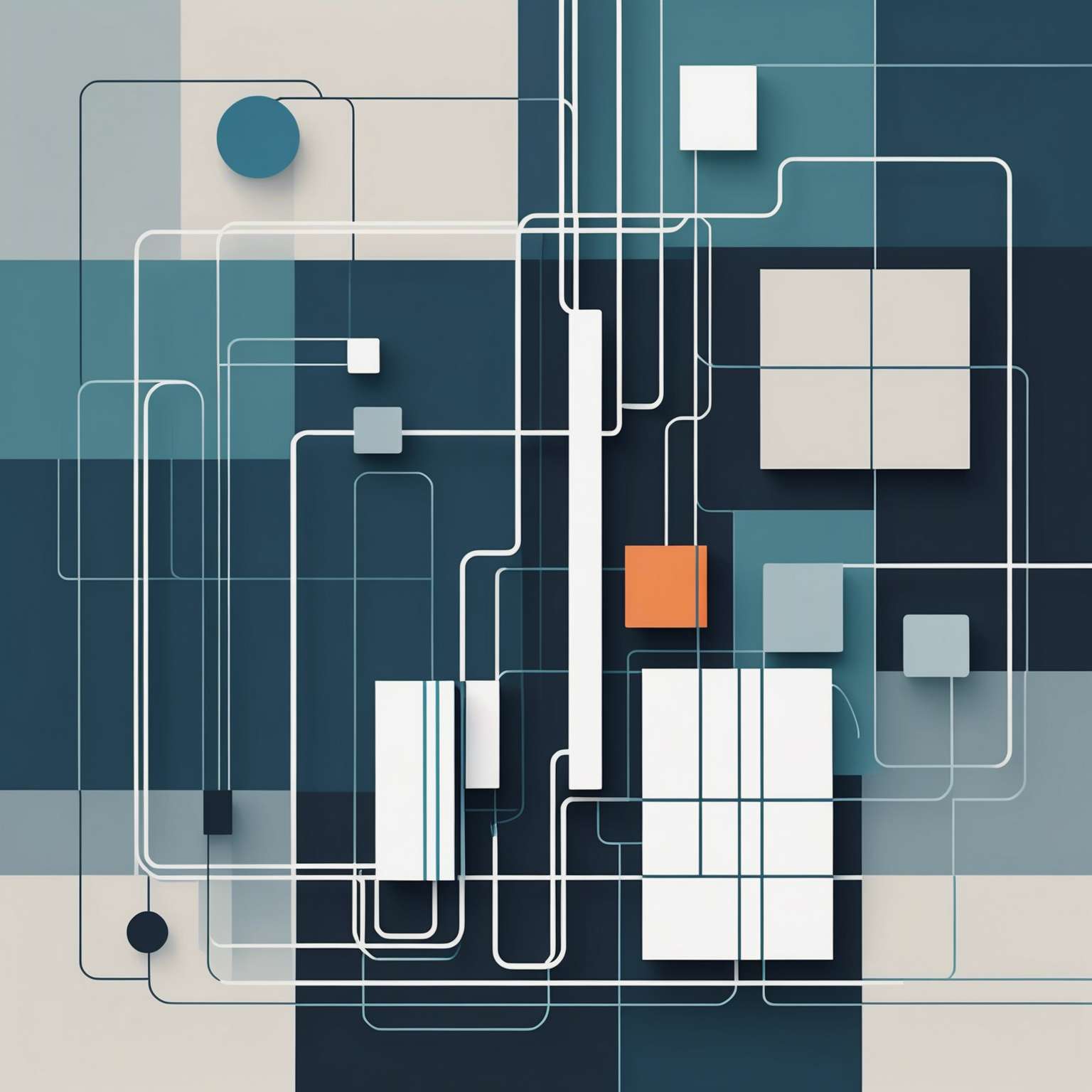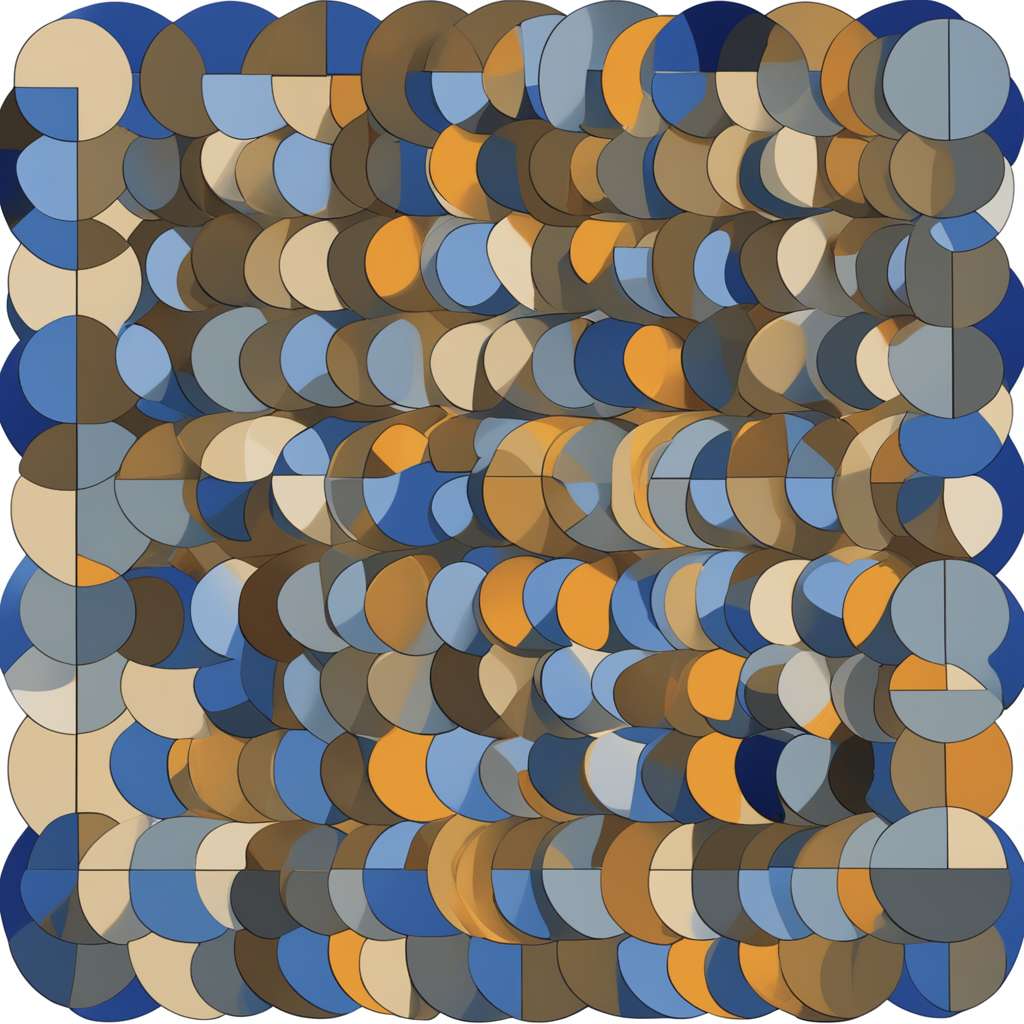E-Mail: [email protected]
- La tassa Zucman propone un'imposta minima del 2% sui miliardari.
- Genererebbe 250 miliardi di euro all'anno a livello globale.
- In Italia, l'1% più ricco detiene il 12,3% del reddito nazionale.
Un imperativo per la stabilità sociale
Nel panorama economico globale, una questione cruciale sta emergendo con forza crescente: la necessità di una tassazione più equa per i super-ricchi. La disparità tra la ricchezza accumulata da una ristretta élite e il contributo effettivo che questi forniscono al bene comune è diventata insostenibile, minacciando la coesione sociale e la stabilità economica. Recenti prese di posizione da parte di economisti di fama mondiale, inclusi sette premi Nobel, evidenziano l’urgenza di affrontare questa problematica.
La settimana scorsa, una lettera pubblicata su Le Monde, firmata da sette premi Nobel per l’Economia, ha acceso i riflettori sulla “Tassa Zucman”, una proposta per introdurre un’imposta minima globale sui patrimoni dei miliardari. Questa iniziativa segue un editoriale simile di Jean Pisani-Ferry e Olivier Blanchard, due economisti di spicco nel dibattito francese ed europeo. La rilevanza di queste prese di posizione risiede nel fatto che, mentre alcuni firmatari come Paul Krugman, Esther Duflo e Joe Stiglitz sono noti per il loro sostegno alla giustizia fiscale, altri come Daron Acemoglu, Pisani-Ferry e Blanchard sono tradizionalmente più cauti su temi politicamente sensibili. La loro convergenza su questa questione testimonia una crescente preoccupazione per la tenuta del contratto sociale.
La “Tassa Zucman”: un meccanismo per una tassazione più equa
La “Tassa Zucman”, proposta dall’economista di Berkeley Gabriel Zucman, prevede l’introduzione di un’imposta minima globale del 2% sul patrimonio dei miliardari. Contrariamente alle imposte che gravano sul reddito, il calcolo di questa tassa avverrebbe direttamente sul valore del patrimonio posseduto, a prescindere dai dividendi o altri proventi dichiarati ogni anno. Questo meccanismo renderebbe molto più difficile l’elusione fiscale, poiché la ricchezza è più complessa da occultare rispetto al reddito. La misura riguarderebbe circa 3.000 contribuenti in tutto il mondo con patrimoni superiori a un miliardo di euro, generando entrate stimate in 250 miliardi di euro all’anno a livello globale, di cui 50 miliardi solo nell’Unione Europea.
In Francia, l’Assemblée Nationale aveva approvato l’introduzione di una tassa Zucman, poi respinta dal Senato a maggioranza conservatrice. La misura francese avrebbe riguardato i patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, generando entrate fiscali per 20 miliardi di euro. Le lettere pubblicate su Le Monde sottolineano che i ricchi non sono mai stati così ricchi. In Francia, ad esempio, nell’arco di quarant’anni, la porzione detenuta dall’1% più benestante della popolazione è quasi raddoppiata, passando dal 7,3% nel 1981 al 12% nel 2023. Nonostante ciò, i super-ricchi contribuiscono in misura minore al bene comune rispetto ad altri gruppi di reddito. L’aliquota fiscale effettiva per i miliardari francesi è solo del 27% del loro reddito complessivo, grazie a sofisticate tecniche elusive, mentre la classe media e la maggior parte dell’1% più ricco pagano un’aliquota media del 52%.

- Finalmente un passo avanti verso una società più giusta... 👏...
- Tassa sui super-ricchi? Soluzione semplicistica e dannosa... 🤔...
- E se invece di tassare, incentivassimo la filantropia...? 💡...
Il caso italiano: un sistema regressivo
Anche in Italia, l’1% più ricco della popolazione ha visto la propria ricchezza aumentare notevolmente, passando dal 6,2% del 1981 al 12,3% del reddito nazionale nel 2023. Analogamente, i redditi molto elevati sfuggono all’imposizione fiscale. Uno studio pubblicato sul Journal of the European Economic Association ha stimato i tassi effettivi per l’Italia, rivelando un quadro simile ad altri paesi, seppur con alcune differenze. Il sistema italiano è debolmente progressivo per gran parte della distribuzione del reddito, con un tasso medio di imposizione che varia dal 40% per i redditi più bassi al 50% per il novantesimo percentile. Tuttavia, oltre la soglia di 80.000 euro di reddito, che rappresenta il 5% più facoltoso della popolazione, la struttura fiscale diviene marcatamente regressiva. Questo segmento della popolazione riceve quasi la metà delle proprie entrate dal capitale, riducendo l’impatto dei redditi da lavoro e sfruttando le discrepanze del sistema impositivo. Di conseguenza, per lo 0,01% dei contribuenti italiani, il tasso effettivo si riduce al 36%, inferiore sia alla media (46,3%) che alla parte più povera della popolazione (40%).
In sintesi, in Italia, chi più ha meno paga, in contrasto con l’articolo 53 della Costituzione, che sancisce la progressività del sistema tributario. La tassa Zucman potrebbe contribuire a correggere questa distorsione. Sebbene un accordo internazionale sarebbe auspicabile, nulla impedisce a un paese di introdurre una tassa Zucman autonomamente, proteggendosi dal rischio di fuga di capitali attraverso misure come l’assoggettamento all’imposta per un periodo successivo al cambio di residenza fiscale.
Verso un futuro di equità fiscale e coesione sociale
La giustizia fiscale non è un lusso, ma una necessità per la sopravvivenza del contratto sociale. Se non si affrontano le sfide attuali, chiamando a contribuire chi finora è stato esentato, si rischia di compromettere la stabilità sociale e di aprire la strada a soluzioni politiche estreme. L’appello dei sette premi Nobel e le proposte come la “Tassa Zucman” rappresentano un passo importante verso un futuro di maggiore equità e coesione sociale.
Riflessioni conclusive: un nuovo patto sociale per il XXI secolo
La discussione sulla tassazione dei super-ricchi non è solo una questione economica, ma un tema profondamente etico e sociale. In un’epoca di crescente disuguaglianza, è fondamentale ripensare il patto sociale che lega i cittadini allo Stato. Una nozione base di difesa del consumatore consapevole ci ricorda che ogni individuo ha il diritto di essere informato e di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la redistribuzione della ricchezza. Una nozione avanzata, invece, ci invita a considerare la tassazione come uno strumento di economia circolare, in cui le risorse vengono reinvestite per il bene comune, creando un circolo virtuoso di prosperità condivisa.
È tempo di superare le resistenze ideologiche e di abbracciare soluzioni innovative che garantiscano una tassazione più equa e progressiva. Solo così potremo costruire una società più giusta, inclusiva e sostenibile, in cui tutti abbiano la possibilità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al progresso collettivo. Riflettiamo, quindi, su come possiamo, nel nostro piccolo, promuovere una maggiore consapevolezza e un impegno attivo per un futuro di equità e giustizia sociale.