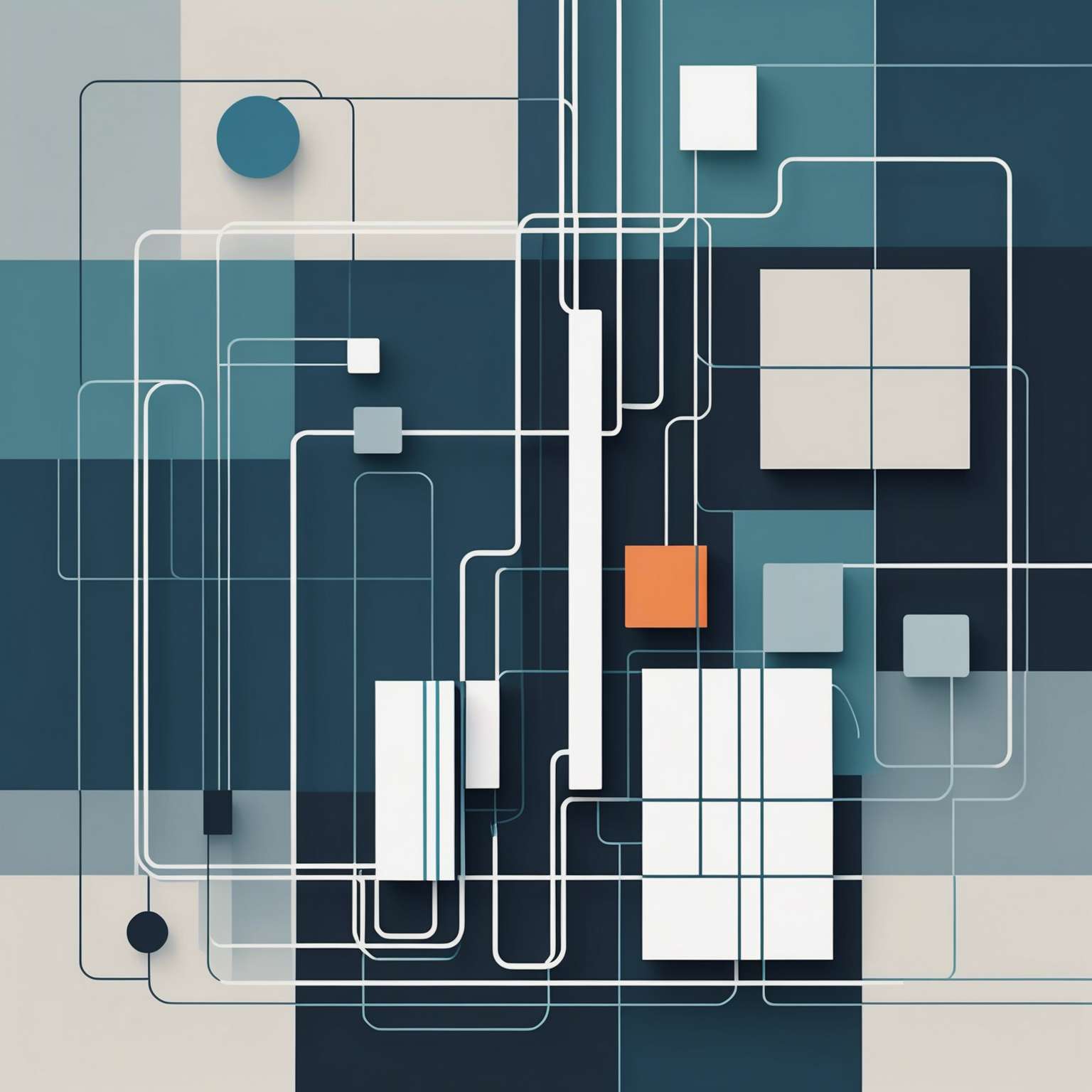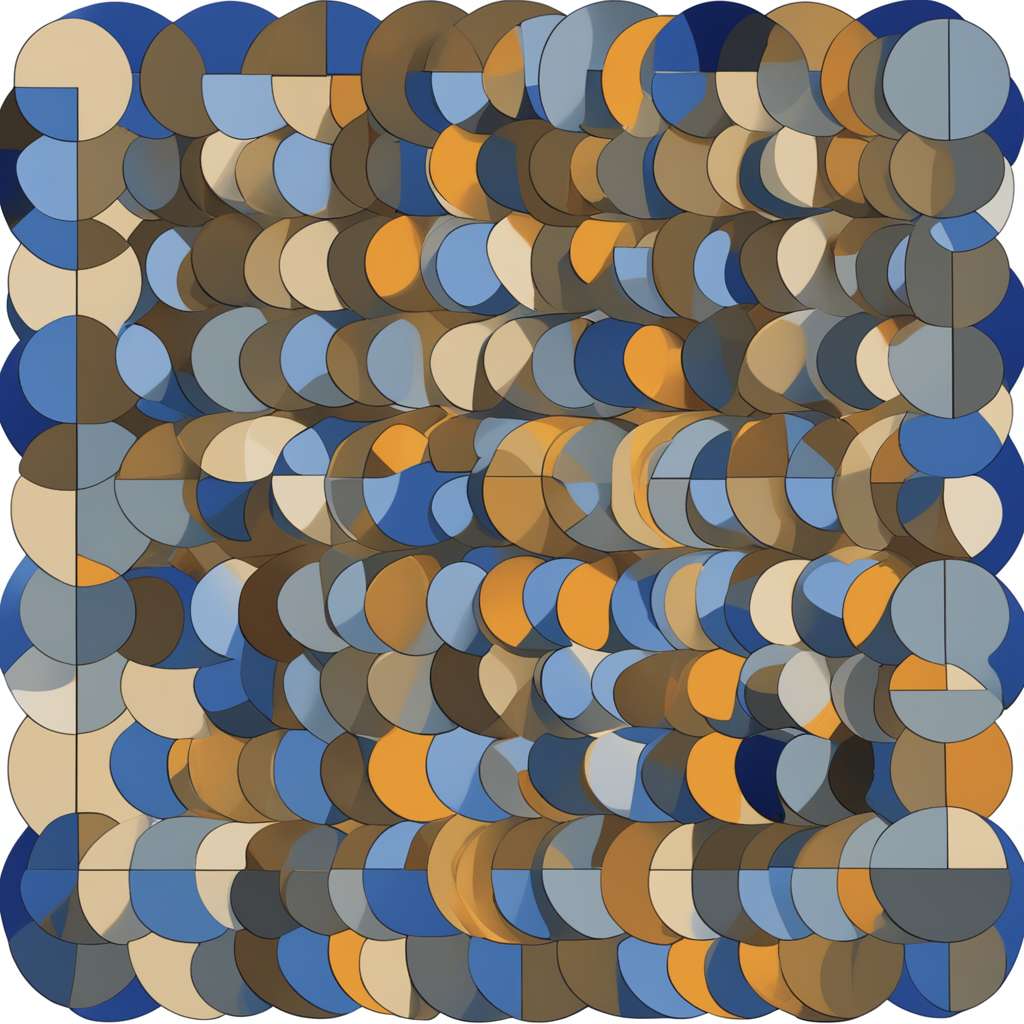E-Mail: [email protected]
- La frazione organica è il 35% dei rifiuti urbani italiani.
- Solo l'80,9% del rifiuto organico viene effettivamente riciclato.
- Il divario tra rifiuti raccolti e riciclati è del 15,8% nel 2023.
Oggi, 27 novembre 2025, ci troviamo di fronte a una sfida cruciale per il futuro della gestione dei rifiuti in Italia. La frazione organica, che costituisce il 35% dei rifiuti urbani, rappresenta un’opportunità significativa per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e promuovere l’economia circolare. Tuttavia, persistono delle criticità che ne ostacolano il pieno sfruttamento.
L’efficienza del trattamento e la qualità del rifiuto organico sono essenziali per il successo degli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani. L’introduzione di una regolamentazione tecnica da parte di ARERA, inserita nei bandi di gara, rappresenta un progresso per innalzare la qualità delle raccolte e per equilibrare i principi di “concorrenza” e “prossimità” nel processo di trattamento. Nonostante ciò, non possiamo attendere il 2028 per riscontrare miglioramenti concreti.
La componente organica dei rifiuti urbani, composta principalmente da scarti alimentari (il cosiddetto “umido”) e da sfalci e potature, costituisce oltre un terzo del totale dei rifiuti urbani, ammontando a circa 10 milioni di tonnellate all’anno, pari al 34,7% della produzione totale. Questa frazione contribuisce per il 41,2% al tasso di riciclaggio nazionale, con un effettivo tasso di riciclaggio dell’80,9%.

Il paradosso del mercato dell’organico: tra obiettivi europei e criticità interne
Nonostante il suo potenziale, la gestione del rifiuto organico si trova al centro di un paradosso. Sebbene dovrebbe spingerci verso gli obiettivi europei di economia circolare e decarbonizzazione, grazie al recupero di materiali e alla produzione di combustibili rinnovabili, è invece oggetto di un vivace dibattito tra logiche di mercato e di prossimità, con la conseguenza che gli investimenti sono bloccati.
L’Europa ci richiede un impegno significativo: entro il 2035 dovremo riciclare almeno il 65% dei rifiuti urbani e limitare lo smaltimento in discarica a un massimo del 10%. Per l’Italia, questo implica una diminuzione del ricorso alla discarica di almeno 7 punti percentuali e un aumento del tasso di riciclaggio di almeno 14 punti percentuali rispetto ai valori attuali (pari al 50,8%.
Tuttavia, negli ultimi anni, il divario tra la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e quella effettivamente riciclata si è ampliato, passando dall’1,3% nel 2010 al 15,8% nel 2023. Questo suggerisce una diminuzione della qualità delle raccolte, con una maggiore presenza di materiali estranei che richiedono rimozione, portando a una superiore produzione di scarti.
L’efficacia nella rimozione dei materiali non desiderati è quantificata tramite il cosiddetto “effetto di trascinamento”, il quale misura la perdita di materiale potenzialmente riciclabile che si verifica in seguito all’eliminazione delle impurità. Negli impianti meno performanti, il rapporto tra scarti e materiale estraneo può superare persino valori di 3, causando non solo una diminuzione dell’efficacia del riciclaggio, ma anche una maggiore quantità di scarti da gestire con costi aggiuntivi, con una conseguente perdita di efficienza sia economica che ambientale.
- 👍 Ottimo articolo! Finalmente si parla chiaro del potenziale sprecato......
- 👎 Che disastro! Siamo ancora troppo indietro con il riciclo organico......
- 🤔 Ma se invece di centralizzare il trattamento, puntassimo su......
- 💰 Il vero problema sono gli interessi economici dietro......
- 🌱 Concentriamoci sull'educazione: differenziare bene è fondamentale......
La competizione aggressiva sui prezzi e l’incertezza normativa
Di fronte a queste sfide ambiziose, il settore del trattamento dell’organico ha attraversato una fase di turbolenza negli ultimi anni. Le tariffe di trattamento in alcune regioni sono precipitate da circa 130 euro per tonnellata nel 2021 a circa 60 euro nel 2024-2025, con picchi al ribasso di 40 euro nelle regioni del Nord. Questa concorrenza accanita sui prezzi dei trattamenti estromette dal mercato numerosi impianti e ostacola nuove iniziative, incluse quelle finanziate dal PNRR.
I dati sulla movimentazione dei rifiuti lungo la penisola documentano l’esistenza di ampie disparità territoriali nell’efficienza del trattamento. Veneto (+398.383 ton), Lombardia (+288.041 ton) e Friuli-Venezia Giulia (+238.344 ton) sono le regioni con un surplus maggiore di capacità di trattamento. Al contrario, Campania (-451.056 ton), Lazio (-236.784 ton) e Toscana (-195.100 ton) sono le regioni dove si riscontra un sistema di trattamento meno competitivo.
Dietro a queste cifre si cela una problematica più profonda: l’assenza di linee guida chiare sul funzionamento del mercato dell’organico. Il Testo Unico Ambientale (TUA) enuncia contemporaneamente due principi apparentemente in conflitto: da un lato garantisce la “libera circolazione” nazionale per i rifiuti differenziati destinati al riciclaggio, dall’altro favorisce il principio di “prossimità”, ovvero il trattamento vicino al luogo di produzione.
ARERA ha tentato di fare chiarezza distinguendo tra impianti “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”. Tuttavia, nel biennio 2022-2023 molte Regioni hanno fatto un utilizzo eccessivo degli impianti “minimi”, sottraendo flussi al mercato anche in assenza di reali carenze di trattamento o fallimenti di mercato.
Nel 2023, una serie di interventi dell’Antitrust, dell’ANAC e del Consiglio di Stato sembravano aver consolidato una direzione precisa: gli impianti “minimi” devono essere impiegati con parsimonia, solo laddove siano realmente indispensabili per colmare carenze strutturali. La “concorrenza” rimane il principio fondamentale. La “prossimità” va valorizzata nell’offerta tecnica delle gare, ma senza distorcere la concorrenza. Tuttavia, all’inizio del 2025, nuove decisioni hanno rimesso tutto in discussione, generando un’incertezza che disincentiva gli investimenti e allontana sia gli obiettivi di riciclaggio sia quelli di produzione di combustibile rinnovabile.
Verso un futuro sostenibile: soluzioni e prospettive per il riciclo organico
Di fronte a questa congiuntura, è necessario un intervento chiaro e coordinato che risolva il problema del “market design” dell’organico. La chiave è rimpiazzare la distanza geografica con parametri oggettivi e quantificabili di performance ambientale ed economica. ARERA ha già implementato indicatori precisi: l’efficienza del trattamento, la quantità di scarti prodotti, la generazione di energia, e le emissioni totali legate al trasporto e al trattamento.
Questi indicatori devono divenire una base solida per le stazioni appaltanti già a partire dal 2026, essendo integrati negli schemi di bando standardizzati elaborati dall’Autorità. In tal modo, un impianto non sarà premiato semplicemente per la sua vicinanza al punto di raccolta, ma perché dimostra di essere più efficiente nel riciclo, producendo meno scarti, generando energia rinnovabile e riducendo le emissioni complessive derivanti da trasporto e trattamento.
Per quanto riguarda la classificazione degli impianti, il tavolo istituzionale che coinvolge MASE, ISPRA e ARERA dovrebbe fornire indicazioni operative chiare alle Regioni entro i primi mesi del 2026, in vista degli adempimenti regolatori. Gli impianti “minimi” dovrebbero essere limitati esclusivamente alle situazioni di carenza nell’offerta di trattamento, come accade in Campania, dove si registra un ampio e persistente eccesso di domanda.
Determinante in questo percorso è la rapida attuazione delle direttive sulla qualità tecnica, estesa ai fornitori di servizi e ai subappaltatori. Non sono più accettabili bandi di gara per l’assegnazione della frazione organica in cui la distanza rappresenti l’unico o il criterio preponderante di valutazione, ignorando fattori come l’efficienza, gli scarti, il recupero di materia, la produzione di energia e le emissioni complessive.
Un Imperativo Etico: Riciclare con Consapevolezza per un Futuro Sostenibile
Amici lettori, riflettiamo un attimo. La gestione dei rifiuti organici non è solo una questione tecnica o economica, ma un vero e proprio _imperativo etico_. Ogni volta che separiamo correttamente i nostri rifiuti, compiamo un gesto concreto per la salvaguardia dell’ambiente e per il benessere delle generazioni future.
Una nozione base di difesa del consumatore consapevole è che la corretta separazione dei rifiuti organici è un atto di responsabilità individuale che contribuisce a un sistema di riciclo più efficiente e sostenibile. Più siamo attenti a non contaminare l’organico con altri materiali, minore sarà la quantità di scarti prodotti negli impianti di trattamento e maggiore sarà la qualità del compost che potrà essere utilizzato in agricoltura.
Una nozione avanzata, invece, riguarda la capacità di influenzare le politiche ambientali attraverso le nostre scelte di consumo. Preferire prodotti con imballaggi compostabili o biodegradabili, sostenere le aziende che investono in tecnologie innovative per il riciclo organico e partecipare attivamente alle iniziative promosse dalle nostre comunità sono tutti modi per contribuire a un futuro più sostenibile.
Ricordiamoci sempre che il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani. Ogni piccolo gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza.
—– Regioni come Campania, Lazio e Toscana rivelano una minor capacità concorrenziale nel sistema di lavorazione.
Il Testo Unico Ambientale (TUA) presenta simultaneamente due concetti apparentemente contrastanti: da una parte, assicura la libera movimentazione su tutto il territorio nazionale dei rifiuti differenziati destinati al riutilizzo; dall’altra, incoraggia il principio di vicinanza, ovvero il trattamento nel luogo più prossimo alla produzione degli stessi.
ARERA ha provato a portare chiarezza identificando diverse tipologie di impianti, categorizzandoli come integrati, minimi e aggiuntivi.
Nonostante questo, nel corso del biennio, diverse amministrazioni regionali hanno fatto un ricorso smodato alle strutture classificate come “minime”, deviando i flussi di materiali dal circuito commerciale anche in assenza di reali impedimenti al trattamento o di evidenti fallimenti del mercato.
Nel corso del 2023, una serie di decisioni da parte di Antitrust, ANAC e Consiglio di Stato sembravano aver definito un indirizzo univoco: le strutture classificate come “minime” andrebbero utilizzate con cautela, limitatamente ai casi di effettiva necessità per sopperire a lacune strutturali.
Il concetto di prossimità dovrebbe essere valorizzato all’interno della proposta tecnica nelle gare d’appalto, pur senza alterare la par condicio tra i concorrenti.
La soluzione sta nel sostituire il criterio della distanza geografica con parametri misurabili e oggettivi relativi alla performance economica e all’impatto ambientale.
In questo modo, un impianto non otterrà vantaggi semplicemente per la sua ubicazione prossima al punto di raccolta, ma perché dimostra una superiore efficacia nel riciclo, minimizzando gli scarti, producendo energia da fonti rinnovabili e abbattendo le emissioni totali legate al trasporto e alle operazioni di trattamento.
Per quanto concerne la categorizzazione degli impianti, l’organismo istituzionale composto da MASE, ISPRA e ARERA dovrà fornire chiare indicazioni operative alle Regioni entro il primo trimestre del 2026, in previsione degli obblighi normativi.
- Documento di consultazione ARERA sull'aggiornamento delle disposizioni per i rifiuti.
- Sito ufficiale ARERA, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
- Rapporto ISPRA sui rifiuti urbani, dati essenziali per il contesto nazionale.
- Pagina ARERA con orientamenti sui bandi di gara per la gestione rifiuti.